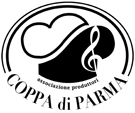Nella Food Valley emiliana esiste un salume che non ha l’urgenza di imporsi, ma la pazienza di farsi riconoscere. La Coppa di Parma IGP è un prodotto di tradizione secolare che dal 2011 porta in etichetta l’Indicazione Geografica Protetta, riconoscimento europeo che lega qualità e reputazione al territorio e alle sue pratiche consolidate. A tutelarne il nome e ad accompagnarne l’evoluzione è il Consorzio di Tutela con sede a Parma, guidato da Fabrizio Aschieri, nato dall’esperienza associativa dei produttori e oggi riferimento per una filiera che occupa oltre cinquecento addetti diretti e dell’indotto.
L’economia di un salume
La fotografia economica dell’ultimo anno racconta una realtà solida che ha saputo navigare un triennio di rincari della materia prima – il taglio del collo suino, cresciuto di prezzo del 21% – chiudendo il 2024 con un fatturato al consumo di 74 milioni di euro. I volumi sono rimasti in linea con l’anno precedente: 3,9 milioni di chilogrammi di carne lavorata, di cui 1,9 milioni destinati al prodotto certificato per un valore alla produzione di 31 milioni di euro. A trainare la crescita è soprattutto il preaffettato, che ha raggiunto 415 mila chilogrammi e 25 milioni di euro, pari a un terzo del giro d’affari; un’evoluzione che consolida la centralità della GDO, oggi al 70% delle vendite, accanto a un canale horeca che vale il 30% in termini di reputazione e valorizzazione.
Anche l’estero manda segnali forti: quota export al 16%, con l’Unione Europea come area principale e il Canada quale singolo mercato più ricettivo.
Il sapere della lavorazione
Dentro questi numeri sta l’identità di un salume che prende forma da un taglio preciso – la porzione muscolare del collo – proveniente da suini selezionati, macellati oltre i nove mesi e con carcasse tra 110,1 e 190 chili. La lavorazione comincia con una rifilatura accurata per contenere le parti grasse in eccesso e prevenire difetti di stagionatura; quindi la salagione a secco, manuale o meccanica, in più passaggi, con sosta in celle a temperatura e umidità controllate per favorire osmosi e disidratazione. Segue un periodo di riposo e la rivestitura in budello naturale, la legatura a spago prima longitudinale poi a spirale, la stufatura e un’asciugatura graduale che prepara la Coppa alla stagionatura. È in questa fase che, tra 12 e 16 gradi e umidità elevata, le legature si allentano e si definiscono profumo, fragranza e consistenza. Il disciplinare fissa un minimo di 60 giorni per le pezzature fino a 2,6 kg e di 90 giorni oltre questa soglia.
L’eleganza al taglio
Al taglio la fetta è compatta, regolare, con il rosso vivo della parte magra che dialoga con i toni rosati delle marezzature. In bocca la tessitura è morbida, la sapidità misurata, il profumo fine e persistente.
È un’eleganza discreta che si ritrova anche nelle accortezze di servizio e conservazione: tradizionalmente si custodisce in luoghi freschi e umidi, e una volta iniziata la si protegge con un panno di cotone leggermente inumidito; non è un caso che, in tempi passati, si usasse avvolgerla in un telo imbevuto di Malvasia dei Colli di Parma.
Un territorio di clima e cultura
L’area di produzione abbraccia le province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Pavia, i comuni rivieraschi del Po nelle province di Lodi e Cremona e San Colombano al Lambro nel Milanese.
È un paesaggio che scende dalle colline alla pianura fino al grande fiume, un “microclima” dove temperature e umidità – insieme con la tradizione norcina e la disponibilità di ambienti idonei – hanno storicamente favorito pratiche di salagione e stagionatura. È in questo equilibrio di fattori naturali e culturali che la Coppa di Parma ha trovato il proprio lessico gustativo.
La lunga memoria
La storia documenta una consuetudine di lunga durata. Se la registrazione IGP è recente, già nel 1680 compaiono attestazioni della produzione locale; per molto tempo la Coppa è stata chiamata “bondiola”, dal nome del budello che la rivestiva, e non di rado nei resoconti di viaggio settecenteschi compare come specialità del luogo.
Nel 1723, per entrare nella corporazione dei Lardaroli, occorreva possedere un certo numero di salsicce e bondiole; negli archivi della Real Casa si rintracciano forniture per le cucine ducali e dati di consumo alla corte di Ferdinando di Borbone. Nell’Ottocento registri di mercato documentano vendite ed esportazioni, mentre ancora nel 1940 la distribuzione oltre la provincia era limitata.
Dal secondo dopoguerra la produzione industriale ha affiancato quella artigianale, salvaguardando i tratti storici del prodotto.
Versatilità in tavola
In cucina la Coppa di Parma esprime una versatilità naturale. Intera, in tranci o affettata in atmosfera protettiva, dialoga bene con crostini caldi, torte salate e pizze ripiene; nel bicchiere, il registro è quello dei bianchi di territorio e non solo, dalla Malvasia dei Colli di Parma al Franciacorta, passando per il Pinot Grigio.
La delicatezza aromatica e la sapidità temperata aiutano gli abbinamenti: l’idea è accompagnare, non sovrastare.
Sguardo al futuro
L’ultimo biennio ha accelerato scelte e assetti. L’affermarsi del preaffettato – che concentra l’intera quota in GDO – risponde a nuove abitudini di consumo e ad esigenze di praticità senza rinunciare alla riconoscibilità dell’origine; allo stesso tempo, il canale horeca continua a svolgere un ruolo essenziale nella narrazione del prodotto, nel servizio al piatto e nei percorsi di degustazione.
Sul fronte internazionale, il recupero delle quote pre-pandemia dice che esiste uno spazio per una salumeria italiana capace di unire rigore di processo e piacevolezza sensoriale.
Il Consorzio, che negli ultimi mesi ha lavorato a un aggiornamento del disciplinare orientato a controlli più moderni e precisi, guarda a questo orizzonte con l’idea che la tutela non sia un vincolo ma una grammatica condivisa per fare qualità.
La forza del tempo
Tutto, in definitiva, torna al gesto originario: una massa cilindrica, una legatura a spago, il tempo che passa. Nella Coppa di Parma IGP la tradizione non è nostalgia, ma metodo che si rinnova.
È così che un salume dalla voce sottile continua a farsi ascoltare, oggi come tre secoli fa, tra le nebbie del Po e i profumi delle cantine.
***
Daniela Devecchi